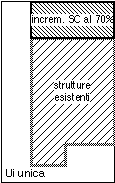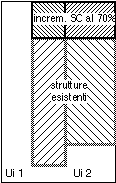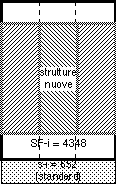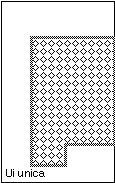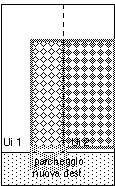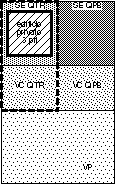Il parametro "superficie
catastale" (Sca) e come applicarlo
introduzione
La perequazione urbanistica riconosce uguali
diritti edificatori a tutti i suoli che si trovano nello stesso stato
di fatto e di diritto.
I diritti edificatori sono espressi da un
parametro che indica la quantità di edificazione per metro
quadro di superficie territoriale.
Tale parametro è l'indice
convenzionale di edificabilità (Ice). La grandezza che esprime
la quantità edilizia, per dare la auspicata certezza del
diritto, deve trovare riscontro in concetti ufficialmente
riconosciuti a scala nazionale.
Poiché la legislazione urbanistica
nazionale non ha fissato un'unità di grandezza urbanistica ben
definita, molte amministrazioni locali hanno preferito fare
più o meno puntualmente riferimento a provvedimenti di legge
di natura amministrativa, come quelli sugli oneri di concessione o
sull'agevolazioni per l'edilizia economica e popolare, che, con
criteri diversi, adottano come grandezza la superficie utile netta.
Tali criteri escludendo dal computo delle quantità edilizie
elementi fondamentali quali piani interrati, balconi, logge,
porticati, tettoie e perfino i muri perimetrali ed interni, possono
facilmente condurre a impatti con l'ambiente e a carichi urbanistici
inaspettati in quanto difficilmente stimabili al momento della
pianificazione.
Altri comuni, come Casalecchio di Reno con
il Prg 1989, hanno adottato come grandezza urbanistica la superficie
utile lorda (Sul) perché di più immediata percezione,
di più semplice misurazione e perché permette di
valutare con omogeneità e certezza sia gli interventi di nuova
costruzione che quelli di trasformazione edilizia.
Nel 1989 il governo ha, come è noto,
riformato profondamente i criteri di misurazione e di accatastamento
delle unità immobiliari con nuove disposizioni che saranno
pienamente in vigore a partire dal 1999 su tutto il territorio
nazionale. Le vecchie disposizioni, basate sul del numero "vani",
limitandosi al semplice conteggio di entità convenzionali
prive di dimensioni, non erano utilizzabili a fini urbanistici. Le
nuove disposizioni, invece, adottando come grandezza la superficie
catastale e come unità di misura il metro quadro, permettono
una rappresentazione numerica molto precisa delle grandezze urbane .
Si può osservare che le nuove
disposizioni riguardano essenzialmente le unità edilizie
correnti, a destinazione abitativa o mista: ma sono queste le
protagoniste della grandissima maggioranza delle trasformazioni che
avvengono nelle nostre città. Infatti, nella definizione delle
"microzone" censuarie è a questo tipo di unità che, per
norma, devono fare riferimento gli uffici del dipartimento del
territorio dell'Amministrazione finanziaria.
Nella superficie catastale rientrano tutti
gli elementi che concorrono a formare una "unità immobiliare",
e cioè una porzione dello spazio urbano - non solo, quindi,
dell'edificio vero e proprio - che sia capace di produrre
autonomamente un reddito.
Poiché l'attività edilizia
privata tende, salvo eccezioni, al massimo sfruttamento economico di
un area urbana - ricercando instancabilmente ogni espediente
contabile che permetta di oltrepassare la misura che il piano
regolatore presuppone - il rispetto delle regole urbanistiche va
perseguito controllando, in primo luogo, la quantità di
oggetti immobili capaci di produrre un reddito economico. E' quindi
logico riferire i controlli alla "superficie catastale", parametro
che la legge impone, senza eccezioni, a tutto il territorio nazionale
per fini del tutto analoghi: la tassazione del reddito immobiliare.
La sommatoria delle dimensioni delle
unità immobiliari non restituisce tuttavia la dimensione
fisica del fabbricato nella sua globalità. Le "parti comuni" e
condominiali (in quanto incapaci di produrre un reddito autonomo o -
in altre parole - di essere compravendute separatamente dalle
unità immobiliari cui servono) restano escluse per legge dal
conto della superficie catastale delle "unità edilizie"
(termine questo con cui il catasto designa l'insieme costituito dal
manufatto edilizio e della relativa area di pertinenza). Balconi e
terrazze (in quanto sul mercato hanno un valore inferiore a quello
delle parti chiuse, ma hanno valore) vengono invece conteggiate solo
in parte, ma vengono conteggiate. Con criterio analogo vengono
contate parzialmente le superfici accessorie di qualsiasi tipo, anche
se sotterranee. Vengono contate perché contribuiscono al
valore delle unità immobiliari delle altre categorie.
Autorimesse individuali e collettive e posti auto privati, anche se
scoperti, vengono contati integralmente.
Adottare la superficie
catastale (Sca) come parametro urbanistico
L'adozione come parametro urbanistico della
superficie catastale comporta però la considerazione di due
importanti aspetti, che riguardano gli effetti che il passaggio
dall'attuale grandezza di riferimento a quella nuova (dalla SUL alla
SCA), può avere:
- sui diritti edificatori spettanti ai
proprietari del suolo oggetto di trasformazione urbanistica
- sugli interventi di conservazione
urbanistica che riguardano il territorio urbano consolidato
Per il primo aspetto, si tratta di stabilire
una volta per tutte il criterio da adottare perché non ne
derivino, in termini economici, indebite punizioni e premi
immeritati. A tale scopo si è scelto un significativo campione
di concessioni edilizie rilasciate secondo i criteri attualmente in
vigore, si è applicato ad esso il nuovo criterio di
misurazione basato sulla SCA, e si è confrontata la
quantità risultante con quella ottenuta applicando l'attuale
parametro della SUL. Individuato il fattore numerico di conversione
tra le due grandezze, questo sarà applicato a indici e
quantità urbanistiche previsti dal piano vigente, adeguandoli
in modo che, a parità di condizioni di fatto e di diritto, non
si determinino squilibri e ingiustizie. Vedi conversione ICE
89/99.
Il secondo aspetto è più
complesso. La disciplina urbanistica vigente da dieci anni a
Casalecchio, sottende infatti la scelta, di carattere strategico, di
contenere la domanda diffusa di nuove costruzioni derivante
dall'insufficiente ampiezza -delle abitazioni esistenti,
privilegiando sull'urbanizzazione di spazi vergini il migliore
sfruttamento dello spazio già costruito.
Il migliore sfruttamento dello spazio
costruito di cui è prevista la "conservazione urbanistica"
avviene sostanzialmente con due modalità, una più
specifica e l'altra più generica:
- La modalità specifica è
quello della "perequazione tipologica" che consiste nell'adeguare
alle caratteristiche prevalenti in un dato ambito territoriale
elementare (ATE), gli edifici che non raggiungono le dimensioni
tipiche del micro contesto urbanistico in cui sorgono. Esso
è regolato dalle cosiddette "VO".
- La modalità generica sta nel
considerare sempre ammissibili, indipendentemente dalle regole
tipologiche che variano caso per caso, tutti gli interventi sugli
edifici esistenti che non comportano l'aumento della SUL. Con la
definizione che il Prg vigente dà di tale grandezza, questo
significa che è sempre possibile chiudere logge, balconi
terrazzi e portici (la cui superficie concorre a determinare la
SUL esistente) , trasformandoli da spazio aperto in spazio chiuso
abitabile.
Mentre l'adozione del nuovo parametro non
incide sostanzialmente sulle specifiche regole dettate dalle vigenti
"VO", costringe invece a ripensare le regole per quegli interventi
generici, che dal Prg vigente sono considerati sempre ammissibili in
quanto non comportano aumento di SUL . Se si considera la SCA invece
della SUL essi comporteranno quasi sempre una variazione della
quantità urbanistica. Si tratta allora, senza toccare il
criterio nazionale di misurazione della SCA, di ammettere
espressamente la cosa, considerando come un diritto dei proprietari
di edifici quello di incrementare la SCA esistente della
quantità corrispondente alla superficie degli spazi aperti che
vengono chiusi e a quella di altri spazi abitabili ricavabili con
interventi che non alterano la proiezione a terra del fabbricato. Un
balcone anche dopo essere stato chiuso conserva infatti sempre la
stessa proiezione a terra. Altri aspetti della questione esulano
dagli aspetti strutturali e strategici del piano regolatore e
diventano materia di regolamento esecutivo.
Secondo le norme tecniche ministeriali, le
unità immobiliari ordinarie possono corrispondere a porzioni
di fabbricati ordinari o delle aree scoperte di loro pertinenza e , a
volte, a interi fabbricati. La
consistenza di queste unità viene determinata misurandone la
"Superficie catastale" (SCA). (Vedi prospetto dei gruppi
e categorie).
Secondo le norme tecniche ministeriali le
unità immobiliari speciali corrispondono, in linea di massima,
a interi fabbricati o a intere attrezzature anche scoperte,
appartenenti a tipologie specializzate, mai di carattere promiscuo.
La consistenza di queste unità viene determinata, come si
è già notato, con criteri ad hoc che possono variare
anche caso per caso. Non si fa riferimento, in questi casi, alla
grandezza "Superficie catastale" né al relativo parametro il
"metro quadro catastale". (Vedi prospetto dei gruppi e
categorie).
Il
concetto di "ordinario" e di "speciale"
La distinzione tra i due concetti è,
ai fine della misurazione della consistenza delle trasformazioni
urbanistico edilizie, della massima importanza, perché separa
due criteri di misurazione: uno reale (quello che riguarda le
unità "ordinarie") e l'altro convenzionale (cui è
giocoforza fare ricorso per le unità "speciali").
Infatti, mentre per l' unità
ordinarie esiste un criterio di misurazione stabilito per legge che
può essere fatto proprio dall'urbanistica, per le unità
speciali è invece la regola urbanistica che deve supplire ,
con idonei criteri di conversione e di classificazione.
L'importanza della questione si
rivelerà in tutta la sua pregnanza nel momento in cui, come
previsto dalla legge, le funzioni di inventario del patrimonio
edilizio nazionale verranno in capo alle regioni e agli Enti locali.
A questo punto i criteri di misurazione del patrimonio "ordinario"
adoperati nella gestione urbanistica e in quella finanziaria, non
potranno non concordare. Solo se il criterio di misurazione
diventerà unico, anche il mercato sarà invogliato ad
abbandonare i variegati usi locali e a considerare i beni
compravenduti con un metro ufficiale, riconosciuto in tutto il
paese.
Una volta che il concetto di ordinario sia
tradotto in termini urbanistici, ci troveremo di fronte a un doppio
ordine di esigenze: da un lato la misurazione dell'esistente, per
potere controllare le azioni di conservazione urbanistica di oggetti
ordinari, dall'altro quello del nuovo per potere controllare la
produzione di nuovi oggetti ordinari.
A regime, il problema dell'esistente
è quello più semplice: la consistenza dei fabbricati
(beninteso in assenza di abusi) sarà quella censita a catasto
e non altra. Dal momento che diventerà compito del Comune
l'aggiornamento e la conservazione dell'inventario del patrimonio
edilizio, gli uffici dovrebbero essere in grado di conoscere a priori
l'esatta consistenza dell'immobile sul quale si vuole intervenire.
L'importanza della questione appare tuttavia relativa quando si
tratta del Tuc, dove la maggior parte degli interventi consiste in
azioni di conservazione urbanistica.
Per il nuovo, la distinzione tra ordinario e
speciale è rilevante per quanto riguarda l'utilizzazione della
QTR negli interventi privati. E' invece irrilevante per gli
interventi pubblici che realizzano la Qpb, in quanto quest'ultima
quantità non rappresenta un diritto della proprietà del
terreno, ma una libera determinazione dell'Amministrazione.
Leggendo le norme tecniche allegate al Dpr
138/98, la distinzione tra "ordinario" e "speciale"se è
inequivocabile in alcuni casi, in altri appare vaga e indeterminata.
Sembrano quindi necessarie più dettagliate istruzioni.
Nell'intento di fare corrispondere alle
accezioni censuarie di "unità ordinaria" e di "unità
speciale", accezioni urbanistiche, ci riferiremo alla classificazione del
territorio.
Attenzione: Per quanto riguarda
il TUC (territorio urbano consolidato) ai fini delle azioni di
conservazione urbanistica si stabilisce quali partizioni considerare
ordinarie (dove il controllo della consistenza avviene misurando la
Sca) e quali considerare speciali dove il controllo della consistenza
avviene con altri parametri, quali la dimensione del lotto, la
superficie coperta, il numero dei piani, l'altezza, la superficie
impermeabilizzata.
Per il TUM e il TPU sarà il piano
operativo a stabilire quale.
Dove è speciale, se trasformazione,
Ice si converte e poi si lavora con altri parametri; se conservazione
non si converte nulla e si opera direttamente con altri
parametri.
Dov'è ordinario, se trasformazione si
applica Ice. Se conservazione si desume Sca dal catasto (o la si
misura)
Per rendere coerente il sistema dei
parametri, attraverso i quali gli strumenti urbanistici regolano
l'esercizio dei diritti edificatori, con i nuovi criteri per la
determinazione della consistenza delle unità immobiliari
urbane, è necessario fare riferimento a più di una
grandezza.
Nel caso si tratti di immobili costituiti da
unità immobiliari ordinarie, la grandezza cui fare riferimento
è sempre la superficie catastale (Sca) espressa in metri
quadrati.
Nel caso si tratti invece di immobili
costituiti da unità speciali, si dovrà fare
riferimento, a seconda delle categorie, ad altre grandezze:
- (Sf) la superficie fondiaria, espressa
in metri quadrati;
- (Sc) la superficie coperta, espressa in
metri quadrati;
- (V) il volume, espresso in metri
cubi
- (H) l'altezza, espressa in metri
- (P) il numero dei piani fuori
terra
- (Se) l'area di sedime
impermeabilizzabile, espressa in percentuale di Sf
- (Vc) il verde privato differenza, in
percentuale tra Sf e Se
Si avrà allora la seguente
casistica:
|
Unità
immobiliari
|
conservazione
urbanistica
|
trasformazione
urbanistica
|
|
Ordinarie
|
quando l'azione urbanistica
consiste di interventi di carattere conservativo, il diritto
edificatorio coincide con la Sca esistente, che potrà
essere incrementata o meno, secondo i criteri perequativi
stabiliti dal regolamento esecutivo sulla base della
descrizione
tipologica
|
quando l'azione di trasformazione
(sia che riguardi un terreno vergine che una porzione di
tessuto da ristrutturare urbanisticamente) ha per scopo la
la realizzazione di nuove unità immobiliari
ordinarie, la quantità di edificazione
corrisponderà alla QTR, sempre espressa in
Sca.
|
|
Speciali
|
quando l'azione urbanistica
consiste di interventi di carattere conservativo, il diritto
edificatorio è quello che deriva dalle disposizioni
del regolamento esecutivo, fondate su parametri diversi
dalla Sca:
|
quando l'azione di trasformazione
(sia che riguardi un terreno vergine che una porzione di
tessuto da ristrutturare urbanisticamente) ha per scopo la
la realizzazione di nuove unità immobiliari speciali,
la quantità di edificazione che rappresenta la QTR,
espressa in Sca, viene convertita in una grandezza diversa,
coerente con la categoria censuaria, cui faranno riferimento
le regole di edificazione.
|
|
Sia che si tratti di conservazione
come di trasformazione urbanistica, può accadere che
una porzione del fabbricato (o dell'immobile) speciale,
venga considerato, ai fini catastali, come unità
immobiliare ordinaria: per esempio, un'abitazione annessa a
un fabbricato industriale (Z01). Ai fini urbanistici la
circostanza è irrilevante, e pertanto la nozione di
specialità prevale su quella di
ordinarietà.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riepilogo
1
Il piano regolatore distingue,
perseguendo la massima coerenza possibile con i criteri che
ispirano il nuovo regolamento per la revisione generale
delle zone censuarie:
|
|
1 - i casi (dove entrano in gioco unità
immobiliari ordinarie) in cui la grandezza urbanistica di
riferimento, alla quale commisurare contestualmente:
- sia i diritti edificatori
- che la consistenza degli
effetti degli interventi
|
è la Sca
|
|
è altra dalla
Sca
|
|---|
|
|
|
|
2 - i casi (dove entrano in gioco unità
immobiliari speciali) in cui i diritti edificatori vengono,
nell'ordine:
|
2.1 - dapprima espressi
in termini di Sca,
|
|
|
|
2.2- quindi convertiti
in grandezze diverse
|
|---|
|
|
|
2.3 - regolati, infine,
mediante parametri coerenti con la grandezza adottata
|
|---|
Territorializzazione
del concetto censuario di "ordinario" e "speciale"
Alla luce del riepilogo 1, si deve
considerare quanto segue.
In un prima fase, fino a quando non sia
andato a regime il censimento del patrimonio immobiliare urbano
secondo i nuovi criteri e, soprattutto, fino a quando la
conservazione dell'inventario del patrimonio non sia passato dal
dipartimento centrale del territorio agli enti locali, la
territorializzazione dei concetti di "ordinario" e "speciale" ai fini
del piano regolatore, non coinciderà sempre con quella
implicita negli atti degli uffici centrali.
E' allora importante che, perdurando fino a
quel momento un indeterminato margine di incertezza, allo scopo di
eliminare fino dall'inizio almeno quelle contraddizioni che
potrebbero rendere problematica l'applicazione delle regole
urbanistiche, il campo di applicazione urbanistico del riferimento
alla Sca, tenda ad essere cautelativamente più ristretto di
quello teoricamente considerabile dagli uffici centrali.
E' meglio, in altre parole, che,
nell'incertezza, immobili che gli uffici centrali potrebbero
considerare "ordinari", siano considerati "speciali" dal piano
regolatore che non viceversa. In questo modo il Comune non rischia di
trovarsi vincolato all'applicazione di un metodo di misurazione
minuzioso, quale quello della Sca, in situazioni dove gli uffici
erariali potrebbero applicare parametri diversi. Ne potrebbero
infatti derivare conflitti tra privati e Comune.
In altre parole ancora, in situazioni di
incertezza, è preferibile per il piano regolatore considerare
"speciali" immobili che secondo i criteri catastali potrebbero essere
"ordinari", che non considerare ordinari immobili che potrebbero
essere speciali.
In vista del controllo delle azioni di
conservazione urbanistica, la territorializzazione farà
riferimento alla classificazione del
territorio che è componente
strutturale del piano regolatore. Quando il nuovo sistema sarà
andato pienamente a regime, la consistenza delle unità
ordinarie sarà sempre quella risultante dall'inventario
conservato presso la stessa Amministrazione comunale.
Per il controllo delle azioni di
trasformazione urbanistica, la territorializzazione avverrà
solo con i progetti urbanistici esecutivi o, se i contenuti operativi
del piano regolatore possono essere sufficientemente dettagliati, in
sede di variante operativa. Nelle azioni di trasformazione
urbanistica che devono dare luogo a complessi immobiliari
catastalmente definibili come speciali, è determinante il
criterio di conversione della QTR fissato dal piano regolatore, nel
quadro delle regole perequative.
|
TUC
|
territorio urbano
consolidato
|
per le diverse articolazioni vedi
la tabella delle
categorie che segue
|
|
TUM2
|
siti estranei urbani
|
speciale
|
|
TUM3
|
siti urbani in trasformazione
controllata
|
progetto urbanistico esecutivo in
corso
|
|
TPU2
|
siti estranei periurbani
|
speciale
|
|
TPU3
|
siti in regime operativo
pianificato
|
progetto urbanistico esecutivo
approvato
|
|
TA1
|
terreni esterni integri
|
i siti rurali sono da considerare
speciali
|
La conversione
in altre grandezze della QTR
|
La conversione non ha senso quando
si tratta di azioni di trasformazione urbanistica che
sfruttano, mediante interventi di carattere pubblico, la
QPB. In tali casi la QPB è espressa direttamente, in
sede operativa, nella grandezza più appropriata. Per
tale ragione dai prospetti che seguono sono escluse (o ne
restano indeterminati i parametri di conversione) le
categorie speciali riferite a tipologie e destinazioni che,
nel caso di Casalecchio, non possono che concernere
interventi pubblici.
Posto allora che:
|
|
|
|
|
|
QTR
|
=
|
ICE x ST
|
|
quantità di
edificazione spettante al terreno
|
|
prodotto dell'indice
convenzionale di edificabilità per la superficie
territoriale
|
|
|
|
|
|
dove l'ICE può avere i
seguenti valori
|
|
Classe
|
|
Indice convenzionale
edificabilità
|
|
TPU
|
|
0,1 mq SCA/mq ST
|
|
territorio
periurbano
|
|
|
TUM
|
|
0,2 mq SCA/mq ST
|
|
territorio urbano
marginale
|
|
|
TUC
|
|
0,4 mq SCA/mq ST
|
|
territorio urbano
consolidato
|
|
|
|
|
|
|
un metro quadro di QTR viene
convertito, a seconda dei casi, in una o più delle
seguenti grandezze secondo criteri dedotti dall'analisi di
casi concreti significativi:
|
|
|
|
|
|
SCA
(superficie catastale)
|
La conversione avviene naturalmente
nel rapporto uno a uno in tutti i casi nei quali la
trasformazione urbanistica comporta la realizzazione di
unità immobiliari ordinarie.
Nei casi di unità speciali,
laddove l'unità immobiliare tende a coincidere con
l'intero fabbricato, il valore della QTR viene aumentato del
25% che corrisponde all'insieme delle superfici che,
corrispondendo, nei casi ordinari, agli spazi comuni
incapaci di produrre un reddito, non vengono conteggiati
(scale, corselli, volumi tecnici ecc)
|
|
SF
(superficie fondiaria)
|
Vi sono casi speciali, che
corrispondono di solito agli insediamenti produttivi
manifatturieri e affini, dove ciò che
urbanisticamente e commercialmente conta non è tanto
il fabbricato, quanto il lotto recintato di pertinenza.
Questo perché è l'intera superficie del lotto
che, contribuendo alla funzionalità dell'insieme,
rappresenta configura lo spazio utile che l'azienda deve
poter essere libera di gestire nel modo più
conveniente ai processi produttivi. Pertanto la QTR è
tradotta in mq di superficie di lotto, e l'utilizzazione di
questo continua a essere normata dal regolamento esecutivo
con parametri di sagoma, quali altezza, numero dei piani,
superficie coperta, distacchi ecc.
Si distingue il caso degli
insediamenti industriali o commerciali che occupano
prevalentemente spazi coperti da quelli invece la cui
attività abbisogna di grandi piazzali a cielo libero
(per es. produzione di prefabbricati o vendita di materiali
per l'edilizia)
|
|
SC
(superficie occupata)
|
Vi sono casi di speciali impianti
dove ciò che conta e produce reddito non sono tanto o
solo i fabbricati, quanto attrezzature a terra come piste,
campi da gioco, parcheggi privati, piazzole di campeggio.
|
|
|
|
torna all'albero
delle regole
|
torna
indietro
|
La
conversione invertita
La "conversione invertita" consiste
nell'esprimere in termini di SCA (superficie catastale) la QTR di un
area da trasformare urbanisticamente che è attualmente
occupata da insediamenti speciali dei tipi individuati al punto
precedente.
La "conversione invertita" rappresenta un
semplice ed equo criterio per determinare - in termini non
negoziabili, coerenti con quelli adottati per stabilire i diritti
edificatori spettanti al terreno vergine - i diritti da riconoscere a
terreni edificati:
- Quando particolari azioni di
trasformazione urbanistica riguardano quelle parti del territorio,
"speciali" per definizione, che sono i siti estranei urbani (TUM2)
o periurbani (TPU2).
- Quando azioni di trasformazione
urbanistica riguardano una porzione di tessuto specializzato
appartenente al TUC.
Nei casi B la conversione invertita si
applica all'intera superficie dell'area, in quanto essa,
rappresendando un lotto che è la maglia di un tessuto urbano,
coincide con la superficie fondiaria SF.
Nei casi A quando si tratta di unità
immobiliari speciali, (gruppi Z01 e Z07) la conversione invertita si applica alla SF
convenzionale, corrispondente all'80% della ST. Il 20 % che viene
dedotto corrisponde allo standard regionale di spazi pubblici che
è il 15% e a una quota di strade di servizio del 5%.
Nel primo caso si deve considerare che le
azioni ammessse o espressamente previste, nei confronti di lotti
industriali o di speciali stabilimenti dismessi, possono avere due
diverse finalità e tre diversi gradi:
|
grado
|
a
|
b
|
c
|
|
finalità
|
i fabbricati
esistenti vengono restaurati e adeguati, senza aumentare il
numero di unità immobiliari
|
i fabbricati
esistenti vengono restaurati e adeguati, aumentando il
numero delle unità immobiliari
|
i fabbricati
esistenti vengono demoliti e vengono realizzate al loro
posto nuove strutture
|
|
1
|
conservazione
dell'uso produttivo industriale
|
Conservazione
urbanistica
|
Trasformazione
urbanistica.
|
|
Le quantità sono
quelle consentite da regolamento.
Non si richiede la
deduzione di aree per standard urbanistici
(vedi
figura)
|
Le quantità sono
quelle consentite da regolamento.
Non si richiede la
deduzione di aree per standard urbanistici
(vedi
figura)
|
E' obbligatoria la
deduzione delle aree per standard urbanistici industriali
(S-i) da cedere gratuitamente.
La superficie fondiaria ,
ridotta in seguito a tale deduzione, è utilizzata per
usi industriali secondo il regolamento (SFI).
(vedi
figura)
|
|
2
|
mutamento
d'uso (direzionale, residenziale ecc.)
|
Conservazione urbanistica
ed edilizia.
|
Trasformazione
urbanistica.
|
Trasformazione
urbanistica.
|
|
Le quantità non
aumentano.
Non è obbligatoria
la deduzione di aree per standard urbanistici, che vengono
monetizzate.
(vedi
figura)
|
Le quantità, se
inferiori, aumentano al massimo:
fino a 0,2 x ST in TUM2
fino a 0,4 x ST in TUC.
L'intervento è
subordinato alla deduzione di aree per standard urbanistici
commisurati al nuovo uso da cedere gratuitamente.
(vedi
figura)
|
La QTR è pari
a:
0,2 x ST in TUM2;
0,4 x ST in TUC
oltre, nel caso vi siano costi di bonifica, a una quota, da
determinare, della differenza tra la QTR e la QTR-i (QTR
industriale) esistente.
La QTR-i si determina in
base a SFI, col criterio della conversione inversa
(vedi
figura)
|
Nei casi C1 e C2 si fa ricorso a un metodo
di conversione invertita.
|
grado
|
a
|
b
|
c
|
|
finalità
|
i fabbricati
esistenti vengono restaurati e adeguati, senza aumentare il
numero di unità immobiliari
|
i fabbricati
esistenti vengono restaurati e adeguati, aumentando il
numero delle unità immobiliari
|
i fabbricati
esistenti vengono demoliti e vengono realizzate al loro
posto nuove strutture
|
|
1
|
conservazione
dell'uso produttivo industriale
|
Conservazione
urbanistica
|
Conservazione
urbanistica
|
Trasformazione
urbanistica.
|
|
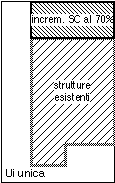
|
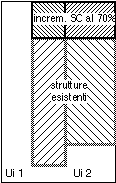
|
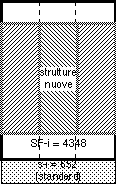
|
|
2
|
mutamento
d'uso (direzionale, residenziale ecc.)
|
Conservazione urbanistica
ed edilizia.
|
Trasformazione
urbanistica.
|
Trasformazione
urbanistica.
|
|
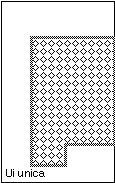
|
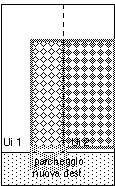
|
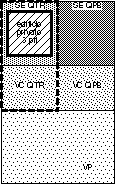
|